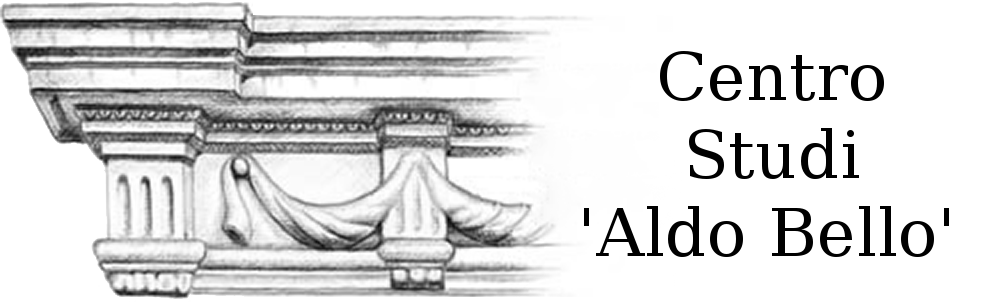Nell’ottobre del 2002 si è tenuto a Torino, presso la Galleria d’Arte Moderna, il convegno internazionale «Le arti del ‘900 e Carmelo Bene».
Artisti,studiosi, critici e giornalisti (e, tra questi, Aldo Bello) hanno ricordato questo rivoluzionario personaggio – originario di Campi Salentina – ripercorrendo il suo percorso artistico nella veste di attore, regista, drammaturgo, filosofo, scrittore e poeta. Aldo Bello ha contribuito con un originale intervento, che qui riproduciamo.
Forte infatti della conoscenza diretta di Bene – complice l’amicizia che li accomunava al pittore Tonino Caputo – e di ore di conversazione con l’artista (sintetizzate poi anche nel capitolo a questi dedicato in Amare Contee) Aldo Bello ci restituisce la poetica di Bene attraverso le sue stesse parole.
Un’officina di conchiglie e rovine
di Aldo Bello
Si andava a cenare al caffè dell’Epoca, di fronte a Porta Pia: rigatoni al pomodoro e mozzarella, con bis incorporato, e vino di Trani, a mezzanotte almeno, comunque quando finivano le prove del Caligola. Tutti estenuati, Carmelo escluso, lui scaricava a quell’ora il surplus adrenalinico, grillo affabulante, marionetta pervasiva, gazzettiere di feroci elzeviri. Teatro? Arte? Letteratura? Tutt’altro. Soltanto variazioni su un argomento monotematico: le donne. Donne angelicate dalla memoria di una deflorazione, donne sublimate dal desiderio di un amplesso, donne callipigie, donne dai seni rinascimentali. Donne tutte donne: dèe-madri che vomitavano figli che la vita avrebbe puntualmente triturato, come il mare macina le conchiglie che arena fra le spiagge. Oppure donne filiformi, come quelle stilizzate – tanto da essere difficilmente identificabili come tali – nella tessitura dei tappeti di Kilim e del Caucaso: donne androgine, amazzoni mastectomizzate, algide silfidi.
Erano furibonde dichiarazioni d’amore. Del suo modo di concepire l’amore, esclusivo e sprezzante. Amo Macbeth – diceva – l’arcaica e superstiziosa lady che non riusciva a togliersi il sangue dalle mani. Ma era una presa di posizione deviante, nel senso dello straniamento brechtiano nell’ironia di una rappresentazione. Perché – diceva ancora – noi possiamo essere solo fabbricanti di dolore, questo è il nostro stato di grazia. Dovremo essere orfani precoci del silenzio, farci silenzio noi stessi, fino alle mute apparizioni, all’abolizione delle vibrazioni laringee, in nome di una rigenerata eufonia, di un progetto che scardini le considerazioni militanti delle scuole, le influenze mutilatrici, le varicose vene italiche, le code dei generi declamate. Mutacismo? Ebbene, sì! Si poteva cominciare da questa condizione nosocomiale, dalle disfonie che maciullino le certezze dei classicisti, degli alunni del narcisismo, dei gorgheggiatori fra zenith e nadir, trasvolanti sans façon dal “do abissale” all’“impotente mi”: roba da beccai ambulanti. Putido repertorio per gonzi.
Il suo tratteggio stilistico era già riconoscibile nei modulati vorticismi della voce, segno più propriamente certo e intrasferibile dell’attore; come nell’impeto del pensiero; nella cosmologia dell’esecuzione in palcoscenico, non declino e ipostasi della recitazione, ma autentico epicentro senza retorica alcuna, omologia creazione-rito senza rito, enfasi senza enfasi della pulsione, bellezza totale derivata, bellezza orrida pura fulgida, senza assi oppositivi, congiunzione di corpo a verbo, anche nel bisogno di ridefinizione, o espulsione dei grumi velenosi: “Voglio dirmi e dirvi tutto, proprio tutto, chi sono, dove sono cresciuto, in che modo parlo e mi atteggio, di cosa ho colpa e perché, che cosa avevo e ho lasciato che mi portassero via, che cosa ho rubato, che cosa di me detesto e tuttavia mi rappresenta e mi condanna, da che cosa non riesco e non voglio venir fuori, quali conti devo chiudere e riaprire, e tanto peggio se per farlo devo sputare in faccia alla critica ancillare. Ecco: io ascolterò il mio ascolto, che è come guardare la mia ombra per giungere alla struttura del mio corpo. È nella phoné il corpo-parola. Non in un esercizio stilistico. È un baratro acustico: la parola è libera di seguire lo pneuma che la genera, o di tornare indietro su se stessa come la chiocciola del labirinto auricolare, o di proseguire – sensitivamente – srotolandosi come un exultet miniato, come conchiglia distesa nella sua spirale. Recitare non significa solo assecondare un impulso egocriptico per una neurolessi terapeutica (siamo tutti malati e inevitabilmente morituri), ma anche scavare con le unghie, stanare il sangue della parola, essere nel testo come un dio che non conosce il perdono”.
Eravamo a casa di Tonino Caputo, alla mano di Campo de’ Fiori, accampati tra cavalletti, sgabelli, cartoni telati abilmente schivati da gatti dai nomi sulfurei. Carmelo lavorava con furore al testo di Nostra Signora dei Turchi, Tonino alle locandine. L’uno e l’altro dal cuore viola e dalla pelle meticcia. Una pelle che, avendola sempre addosso, inesorabilmente, a chi poteva metter paura o fare torto? Carmelo citava Pirandello: “Me lo fate voi il torto, credendo ch’io non abbia o non possa avere altra realtà fuori di codesta che mi date voi; la quale è vostra soltanto, credete: una vostra idea, quella che vi siete fatta di me, una possibilità d’essere come voi la sentite, come a voi pare, come la riconoscete in voi possibile; giacché di ciò che possa essere io per me, non solo non potete saper nulla voi, ma nulla neppur io stesso…” .
Avrebbe ricordato quei giorni mentre si struccava nel camerino del teatro Manzoni: “Scrissi in meno di un mese Nostra Signora, romanzo. Sin dalle prime pagine ero convinto di tirar fuori un gran libro. E così fu ( la modestia: jamais couché avec…), anche se trascurato dagli scribi specifici. Nostra Signora non è soltanto una “geniale parodia della vita interiore”, un Des Esseintes smontato e irriso. Per nulla. E’ ben altro. E’ il più bel saggio, in chiave di romanzo storico, sul mio sud del Sud. Fatelo leggere e raccontatelo a quegli indigeni, e se lo troveranno, naturale, addosso, come un fado del loro bardo più grande”.
Il suo sud del Sud. La sua Magna Grecìa. E la Grecìa, la Piccola Grecia Salentina: dove il pensiero depensa, si spensiera via via scendendo giù fino al Capo di Leuca. Questa terra è il depensamento del pensiero del Sud.
E avrebbe citato da Sono apparso alla Madonna: “Ci si trova immersi in qualcosa che mai ebbe un inizio: un’etnia sposata a una vita immaginaria. Da inventare”. Ouverture per la biografia: “Sono nato a Campi Salentina, pianura sconfinata agricola, di grano, vino, ulivi, e tabacco, soprattutto tabacco: un Atlas di tabacco, con donne d’ogni forma e d’ogni forme e d’ogni età che lo lavoravano. Millequattrocento tabacchine: una montagna di nudo donnesco animale. Accanto a questa montagna, tre ordini religiosi: scolopi, salesiani, gesuiti. Latino e greco antichi, anche parlando del più e del meno, poi latino ecclesiastico, e Lecce, la città come premio o come castigo. Servivo più messe al giorno, prima d’entrare in aula, reduce dagli altari dove avevo vezzeggiato fin dall’alba le mie splendide madonne bionde, biondissime come Cerere, un po’ pagane, eseguite secoli prima dai maestri cartapestai leccesi. Da questo paradiso-stupore, (tale è l’infanzia, quando non si è avuta la sventura di nascere in città), e dalle mie meravigliose madonne, rientravo poi nella mia casa, nella montagna di tabacco e di letame, e in quella delle donne…Poi di nuovo in chiesa, con il latino deformato, e anche lì donne, legioni di donne, cori di donne… Rituali nauseanti. Li trovavo già allora un oltraggio alla religiosità. Il culto come oltraggio al dio assente mi avrebbe poi destinato a quella rivoluzione teatrale copernicana, alla sospensione del tragico, al rifiuto di essere nella storia, in qualunque storia, anche e soprattutto in scena. Da buon settenne iconoclasta, dimenticai quelle meravigliose madonne di cartapesta, e in nome della pura assenza ripresi a quelle Veneri la madonna che ero io. Fu questa la mia prima crociata ai danni dell’immagine…”.
Un uomo di teatro che ha avuto qualcosa dalla sua terra? “No, no. Io faccio un teatro a levare, cioè a togliere di scena, e una terra può darti solamente questo, esattamente tutto quello che ti nega, tutto quello che non ti dà. Ti espelle, cioè ti mette al mondo, e non ti dà niente. Ecco, forse questa è l’unica chance di che si nasce laggiù, o con che si nasce, si è nati, si è stati nati, laggiù…”.
L’enfant prodige del teatro e le risse con i critici e col pubblico. Nel camerino, un momento di abbandono al cospetto del registratore: “Quanta nostalgia per quell’énfant che non c’è più, per le polemiche d’un tempo. Ora sono soltanto prodige… Ora si colmano i palalidi le piazze le corti i boulevards, e alla fine ci sono gli applausi, vale a dire il più alto tributo d’incomprensione. Il fanciullo che ero è sparito con le polemiche, sostituito dalle incomprensioni e dagli applausi. L’incomprensione, quella sì, ti sarà sempre fedele, non ti lascerà mai…
Il poeta dell’elettronica: “Io svendo quello che faccio per fare affermare il teatro della voce che però, oggi, non è concepibile senza l’elettronica. L’elettronica non si limita a vestire la voce: è la voce. Ma occorre sapere come usarla al servizio della musicalità, e, per ora, io sono il solo. Gli altri usano i microfoni come amplificatori per le loro voci, non sanno che questi strumenti vanno suonati, non urlati”.
Macbeth è un fenomeno musicale, è soltanto musicalità. Ma attenzione: musicalità non vuol dire musica, non ha niente da spartire con i generi, “e d’altro canto il mio è un teatro degenere”. Non basta essere musicisti per essere musicali. Di esseri musicali ne nasce uno al secolo, “voi siete stati fortunati perché ne avete avuti due, me e Nijinski. Grazie alla mia musicalità sono anni e anni che mi faccio intendere da inglesi, cinesi, afgani, tutta gente che non conosce la nostra lingua e che percorre con me non un sentiero ma un linguaggio: questo è della musica che non ha frontiere. E io ho realizzato tutto ciò con la parola, con la luce, col silenzio. Cioè: da tutta una vita io tolgo di scena. Sono partito dalla crisi del teatro per giungere al fascino, alla vita del teatro della crisi. Mi sono escluso dall’io, mi sono battuto per demolire me stesso, e, attraverso me stesso, il teatro di prosa. E, se è vero che la fonetica è la dialettica del pensiero, ho riconsegnato il mondo della scena alla struttura. Come ci sono arrivato? Togliendomi di mezzo”.
Perciò riteneva riduttivo, per sé e per l’elettronica, esser definito poeta. Partiva da Hegel, il quale dice che tutto è dentro “Io vi porto questo ‘dentro’ con la voce che vuol dire sinfonia, perché la voce umana non è uno strumento: è un’orchestra, la più bella orchestra che ci sia”. Nella phonè l’elettronica è fondamentale, non è una componente del linguaggio: è il linguaggio, così come il linguaggio non è una parte dell’esistenza, ma è l’esistenza. “Al contrario dei canti d’opera, che danno aria alla voce e che portano tutto fuori, modulando la voce solo una volta che l’hanno espulsa, io devo modulare dall’interno, ma le modulazioni diaframmatiche sono le stesse, soprattutto nel fraseggio, sono modulazioni di orecchio e mentali. Ecco perché la visione non esiste. Svanire nel dire, ecco il miracolo”.
(E l’un l’altro avremmo raccontato, di lì a molti anni, di noi proiezioni incognite di gioventù picare, di scorridori di vergini piste verso nessuna radura perché non avesse nome alcun ri-morso. Fummo poco o nulla da dire a qualcuno, meno ancora da rendergli, da rappresentargli in cambio dell’accanita scommessa su di noi scampati alla zagaglia martirizzante di terra d’Otranto e all’oltraggio turchesco. “D’ora in poi non parlerò con nessuno”, disse Carmelo trangugiando acqua minerale. O più probabilmente birra. “Oppure sì”, sembrò riflettere, “ma solo col vento, che va e viene senza ragione, ed è cieco, non ha pensiero”. Tonino annuiva: “Riapparirai alla madonna, cioè alla folla che vedrà in te, al massimo, un puntino bianco in cima a una torre. Sarà tattile la tua voce”. Voleva abolire anche quella, forse? Inabissarla nelle ‘ignote lontananze’ di Huizinga, per farla riemergere, poi, in echi definitivamente aurorali, da inizio del mondo?
“Da qualche tempo”, confidò, “amo la stolta malinconia del mare. E’ come stare in riva alla vita. Perciò una volta o l’altra tornerò a Otranto”. Ora le sue ceneri respirano salsedini ondulari, in questo estremo Oriente peninsulare che per primo è toccato dai barlumi proclivi del sole).